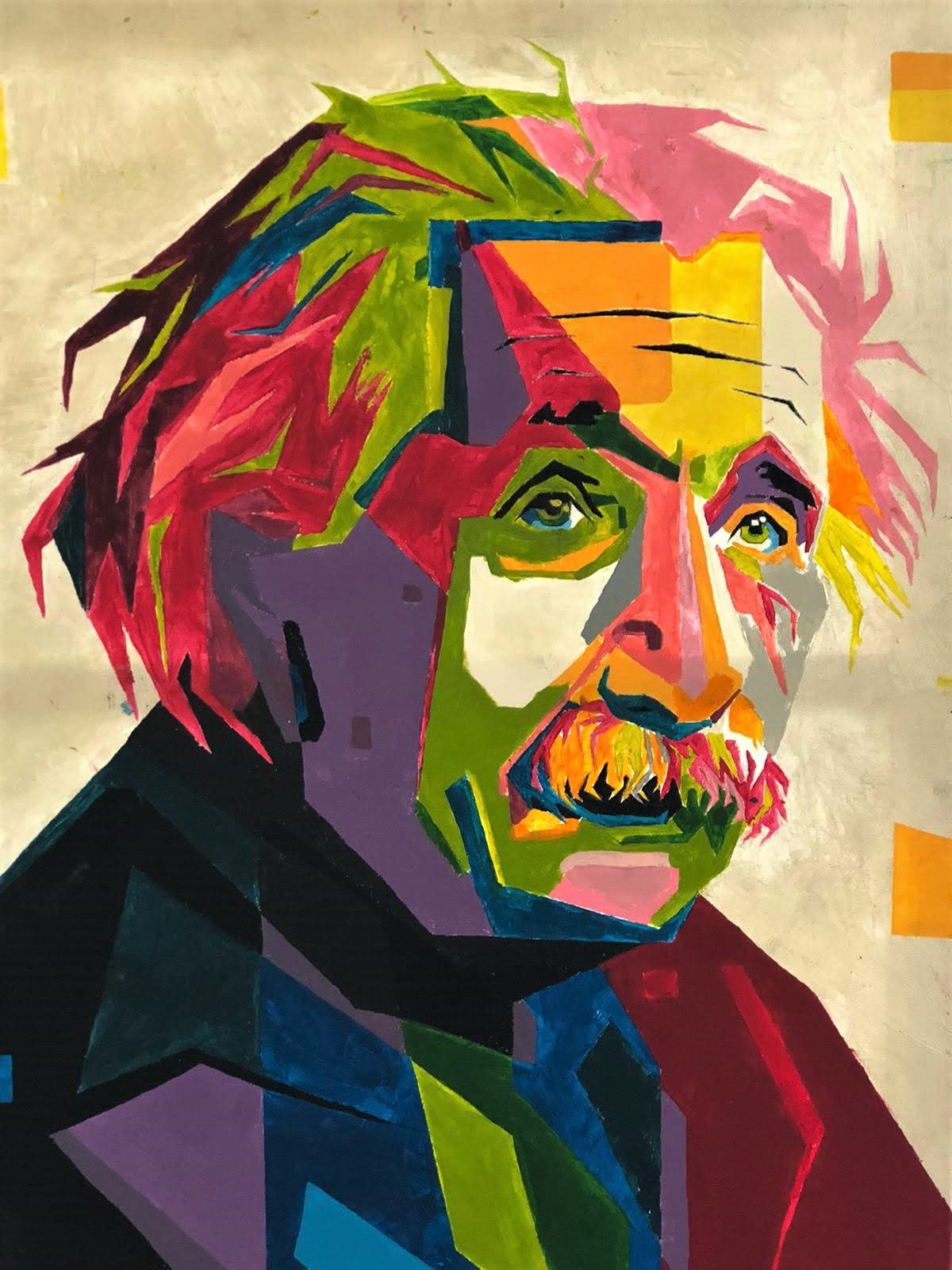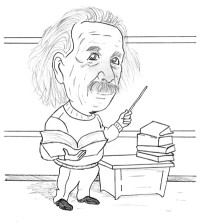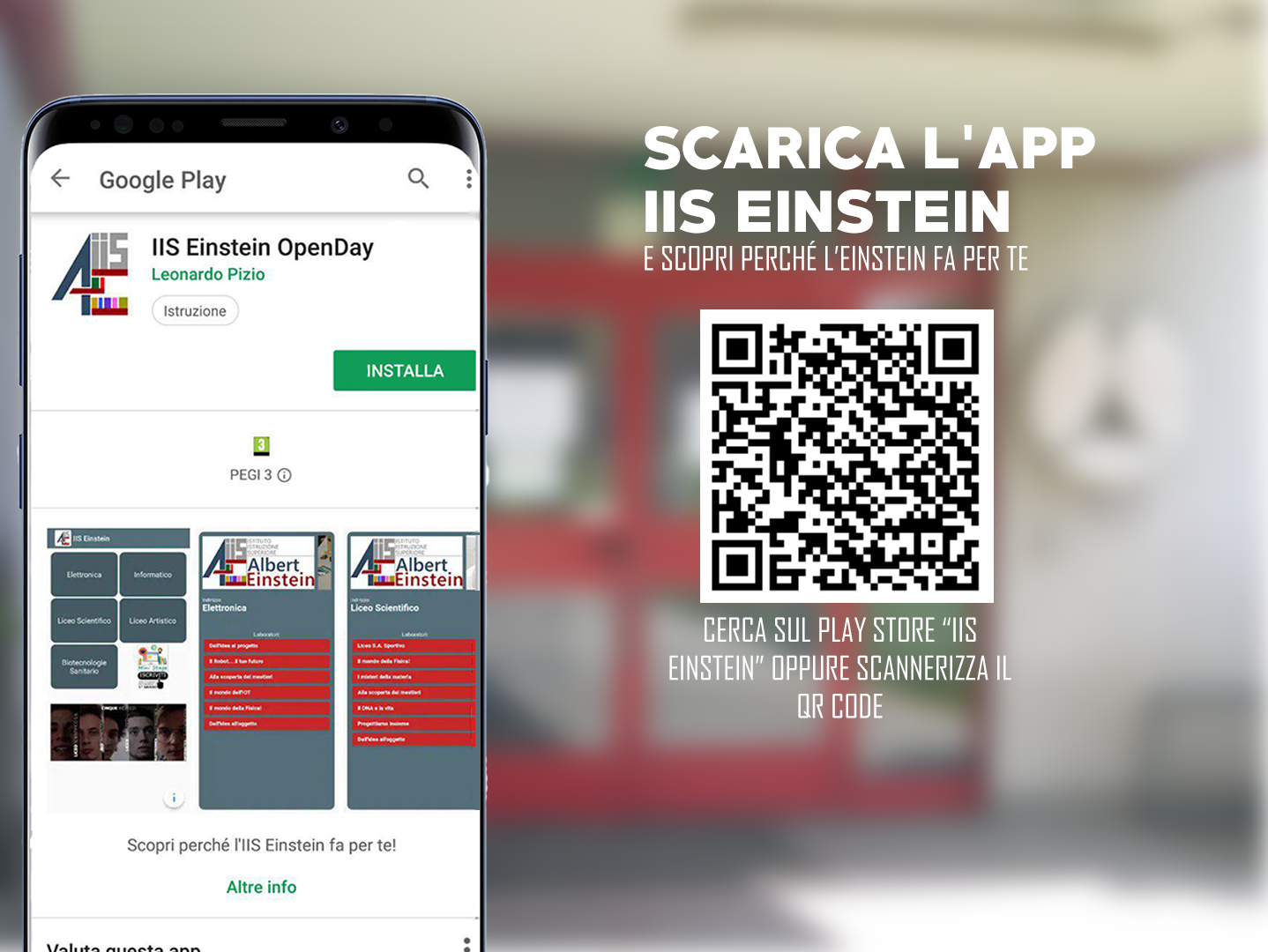SUL CELEBRARE IL GIORNO DELLA MEMORIA. Che cosa fare in classe il – e del – 27 gennaio?

Desidero cominciare queste righe dalla resa di un sentimento di imbarazzo: il mio, di docente – per giunta di Lingua e letteratura italiana e Storia – conseguente alla decisione di dedicare doverosamente (e, beninteso, del tutto convintamente) le lezioni del 27 gennaio scorso ai temi del Giorno della Memoria. L’imbarazzo deriva dalla previsione del fatto che le studentesse e gli studenti finirebbero per ricavare un’impressione (che forse, francamente, in una certa misura sperimento anche io) di retorica polverosità, o persino di stanca scontentezza, dalla proposta, o almeno dal mio eventuale ricorso al consueto repertorio di strumenti: immagini, testi, racconti, film (da Schindler’s List, a La vita è bella, passando da Il bambino con il pigiama a righe). Il limite – voglio sottolinearlo con forza – non è interno a questi oggetti culturali ed estetici; ognuno dei quali – opportunamente interrogato – è in grado di esprimere una potenza significante ed emotiva sempre impressionante. Essi tuttavia (è una mia, ma credo da molti condivisa, sensazione a pelle) sono con il tempo caduti vittime del tipico processo di insistente ripetizione e di conseguente noiosa banalizzazione di tutto ciò che – per propria sfortuna – diventa funzionale alla celebrazione delle cosiddette feste comandate; per chiarire: vedere nella giornata di cui stiamo parlando i palinsesti televisivi riorganizzati intorno ai titoli di film che ho citato prima, e le home page dei giornali on line virare – sostanzialmente nelle stessa maniera ogni anno – verso il colore seppia delle fotografie dei famosi treni merci comincia a sapere, o sa già da un po’ di tempo, di una cosa che si fa perché va fatta; e domani si ripone tutto in soffitta fino all’anno prossimo, come accade con le decorazioni natalizie, che proprio da poche settimane abbiamo sgombrato dalle nostre case (e che, diciamocelo, durano una vita e talvolta, a guardarle bene, possono apparirci improvvisamente invecchiate e fuori moda). Potremmo ricorrere – per esemplificare questo processo – anche all’esempio di quei grandi romanzi che contengono le tensioni, nel bene o nel male, del vivere umano; ma che – magari per il fatto di essere stati letti per la prima e magari anche per la seconda volta come compito nelle estati dai dodici anni in poi – finiscono per essere inseriti dai potenziali (e mai compiuti) futuri lettori nell’armadio virtuale delle “rotture di …” (ciascuno scelga liberamente l’oggetto della rottura).

foto della giovane prigioniera Czeslawa Kwoka scattata da Wilhelm Brasse
Quest’anno – 2023 – mi viene in aiuto, per dare corpo a questi pensieri e in fin dei conti a dare legittimità a queste sensazioni di cui un po’ mi vergogno, una voce alta e autorevole: quella della senatrice e testimone della shoah Liliana Segre: “Basta con questi ebrei, che cosa noiosa”. Lo dice, dando voce a un timore, lei stessa.

E dunque, che cosa fare in classe in questo – e di questo – 27 gennaio? Faccio la scelta che mi mette più a mio agio: non bluffare (cosa che verrebbe rapidamente smascherata), ma piuttosto esporre agli studenti i miei dubbi intorno non al senso della giornata, ma alla modalità di celebrazione. Comincio proiettando sulla lavagna l’articolo con la pessimistica battuta di Liliana Segre. Ed ecco che – autorizzate dalla mia introduzione e, ancora di più, dal suo autorevole parere – anche dai banchi delle studentesse e degli studenti iniziano ad alzarsi simili o ulteriori considerazioni intorno alla sempre minore messa a fuoco del significato e del valore della Giorno della Memoria. Da qui, arrivare alle vere e proprie dichiarazioni di disinteresse o persino di fastidio da parte di alcuni (il cui esercizio di franchezza ha dato un contributo molto grande alla lezione-discussione in corso) nei confronti di questa ricorrenza il passo è stato breve. Un sintetico campionario di quanto raccolto: “Sì, ma prof, sempre la solita storia”, “Ho già visto – tra medie e superiori – il tale film cinque volte”, “La shoah è stata una tragedia, ma è storia passata, alla quale sono seguite altre tragedie: quindi anche basta, so già tutto”, “Perché dobbiamo ricordare proprio questo sterminio e non altri?”, “In fin dei conti, con tutto il rispetto, non riesco a empatizzare fino in fondo con gli ebrei di quell’epoca: io non lo sono e vivo nel presente”. Poi un’ulteriore domanda, che mi dà l’occasione di fare il passo successivo che avevo intenzione di compiere: “Ma prof, questa [indicando la fotografia della senatrice Segre rimasta visibile sulla lavagna] che cosa ci vuole dire?”.

Questa domanda centra – a mio avviso – il nodo cruciale: che cosa si vuole, e anche noi docenti, che cosa vogliamo dire nello spazio dedicato alla memoria dalla shoah? D’istinto mi rispondo: qualcosa che si innalza da quel drammatico scampolo di storia del XX secolo, e va al di là del tempo e dello spazio, e così si attualizza; per parlare dell’uomo, della sua identità visibile e dei suoi abissi. Siamo nel perimetro di quelle cose che, a mio parere, la parola letteraria (mi scuso per la deformazione professionale) riesce a dire meglio rispetto ad altre modalità di comunicazione. E in questa direzione avevo cercato. A questo punto, un apparente paradosso. La risposta arriva da un altro di quegli oggetti culturali maneggiati talmente tante volte da apparire usurati, già visti e rivisti: Se questo è un uomo di Primo Levi (il discorso sul torto fatto a questo grande autore di letteratura attraverso la sua “riduzione” a semplice memorialista andrà fatto in un’altra circostanza). Trovo ciò che cerco non proprio all’interno del libro, ma sulla sua soglia, in quella paginetta introduttiva (che spesso si salta) redatta da Levi per chiarire in anticipo le intenzioni sottese alla propria scrittura. Quel breve testo, insomma, che comincia con: Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, in cui l’uso della parola ‘fortuna’ è talmente scioccante da lasciare intendere che nelle righe successive si annidi qualcosa di più di una semplice noterella introduttiva.

E infatti, poco sotto: questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo. Questo dice Primo Levi – sottolineo: lo dice Primo Levi – all’avvento degli anni Cinquanta del Novecento, all’epoca della pubblicazione del romanzo. Ne traggo la conferma che oggi, nel 2023, è da un lato assolutamente necessario tramandare la storia di quegli accadimenti; ma che, dall’altro, il continuo ripasso – a cui a volte capita di ridurre la funzione della Memoria – di questo capitolo di storia non sembra un compito poi così necessario. C’è infatti una possibilità molto più carica di valore, indicata dallo stesso Levi che prosegue presentando il suo libro come funzionale a uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano. Siamo finalmente entrati nella dimensione di riflessione universale (e quindi anche attualizzante, e che coinvolge ciascuno di noi) a cui sempre vorremmo arrivare accostandoci a questi temi. A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è nemico”: a molti, può accadere. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente: altrove Levi rifiuta l’etichetta del profeta, e condividendo il suo sguardo illuminista ci associamo a lui, limitandoci ad accogliere come una proficua coincidenza la similitudine con la malattia infettiva, che a noi oggi può parlare con particolare efficacia. Il virus dunque c’è, entra nel corpo, si annida; potrebbe rimanere lì fermo, inerte, a lungo, forse per sempre. Dunque ne ignoriamo la presenza. Ma c’è. E, per la verità, non è proprio del tutto invisibile: si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Il darsi dell’handicappato, o del “mongolo” tra compagni di squadra per un passaggio sbagliato (a me è personalmente capitato di sentire ancora la stessa parola ‘ebreo’); il deridere una persona che si sa o che si ritiene essere omosessuale (quante volte un docente sente, nell’arco di una sola giornata, pronunciare la parola ‘frocio’ nei corridoi scolastici, e poi sentirsi rispondere – dopo avere reagito – che “diciamo per scherzare”?); il mugugnare al banco del bar, tra conoscenti o persino tra estranei, al passaggio di un uomo o di una donna neri, o orientali, o abbigliati secondo i canoni di un credo religioso ancora considerato altro da quello più tipicamente locale. Rispetto a tutto ciò Primo Levi è lucido, misurato nella reazione: dal giorno successivo non comincerà una nuova shoah. Ma il virus c’è, e occorre sorvegliarlo: sappiamo ormai bene che anche il caso del soggetto asintomatico, ma positivo alla rilevazione del virus, deve suscitare un’attenzione. Perché, quando – riprendendo le parole di Levi – i singoli atti si allineano in un sistema di pensiero, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. Difficile dirlo più chiaramente: anche i sintomi più modesti – i quali senz’altro conosciamo anche nella nostra esperienza attuale – potrebbero, per quanto in maniera non frequente – virare in malattia; e poi in epidemia. Per questo la storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.

Primo Levi
E dunque, per tornare alla domanda di partenza, che cosa dire, e che cosa fare dire alla Storia nella Giorno della Memoria. Dal testo di Primo Levi ricavo questa indicazione: conosciuta la Storia (che è un fatto necessario che non intendo sminuire) non sembra necessario avvitarsi su di essa in maniera ripetitiva; occorre piuttosto illuminarne quei tratti che riguardano la vicenda umana in generale, non temendo di riconoscerne le tracce nel presente. Andare fisicamente nei luoghi della memoria, vedere il proprio piede calcare il legno dei vagoni e accostarsi al metallo delle pietre d’inciampo, ciascuno con la percezione di sé e dei fenomeni del presente, potrebbe ad esempio produrre cortocircuiti di significati inaspettati, ma di certo efficaci (come ho visto accadere in molti lavori svolti nella nostra stessa scuola, in cui la voce o la penna delle studentesse e degli studenti mi è sembrata produrre un collegamento tra Storia remota e sensibilità individuale e presente). Non avrei, inoltre e infine, timore – né come cittadino, né come insegnante – a esplicitare i parallelismi: quanto sarebbe potente, all’interno del Memoriale delle Shoah o di fronte alla casa di una famiglia deportata, ascoltare dopo le testimonianze di allora quella di una persona disabile bullizzata, di una persona migrante condannata al ruolo di perenne straniera, di una persona o di una coppia omosessuale a cui è stato negato l’affitto di un appartamento, di un giovane o di una giovane rom isolato come se fosse lui un untore. E naturalmente sarebbe ancora ugualmente potente riascoltare le parole dei testimoni delle deportazioni di allora, rivedere le fotografie in bianco e nero dei treni, e anche assistere a una nuova proiezione di Schindler’s List: facendolo – durante un viaggio di istruzione – sul molo di Lampedusa, nelle sale del Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo sulla stessa isola, di fronte alla panchina dove è stato malmenato un senzatetto infreddolito durante il sonno, nei campi dove alcuni lavoratori stagionali conoscono la condizione della moderna schiavitù. E così via. Senza trascurare né tantomeno mancare di rispetto alla specificità storica di ognuno di questi fatti, ma per riattivare con simili contaminazioni la Memoria, e lasciarci condurre nello studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano che darebbe compimento alla forza del libro di Primo Levi; e, in ultimo, per smentire i timori di oblio di Liliana Segre.
Prof. Marco Fumagalli

Angolo del cimitero di Lampedusa riservato alle sepolture senza nome dei migranti (foto scattata dall’autore)