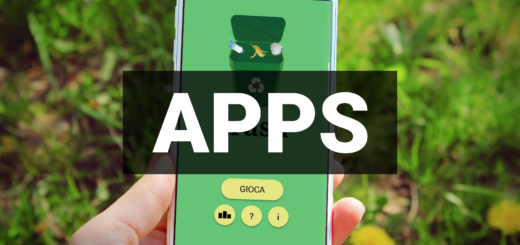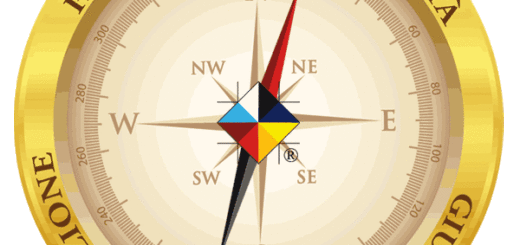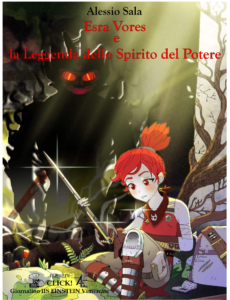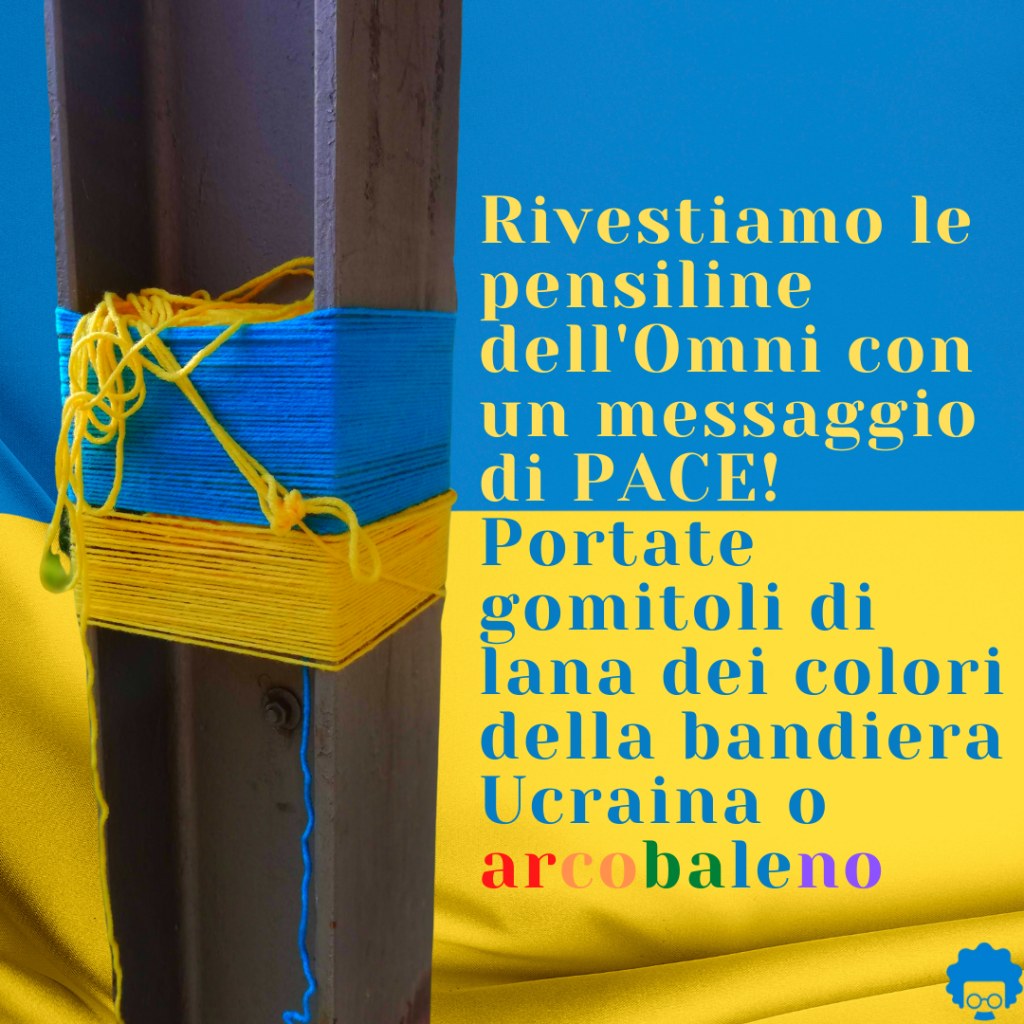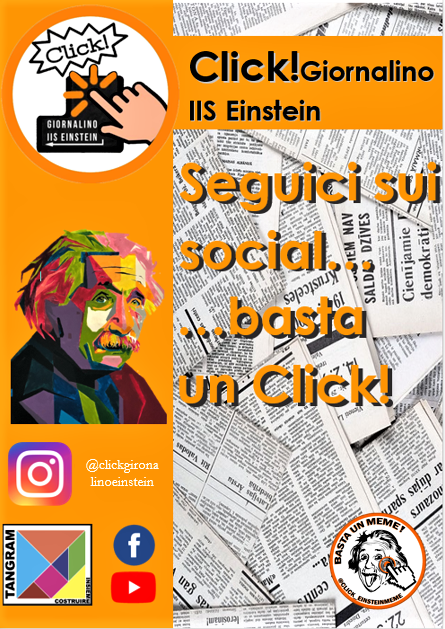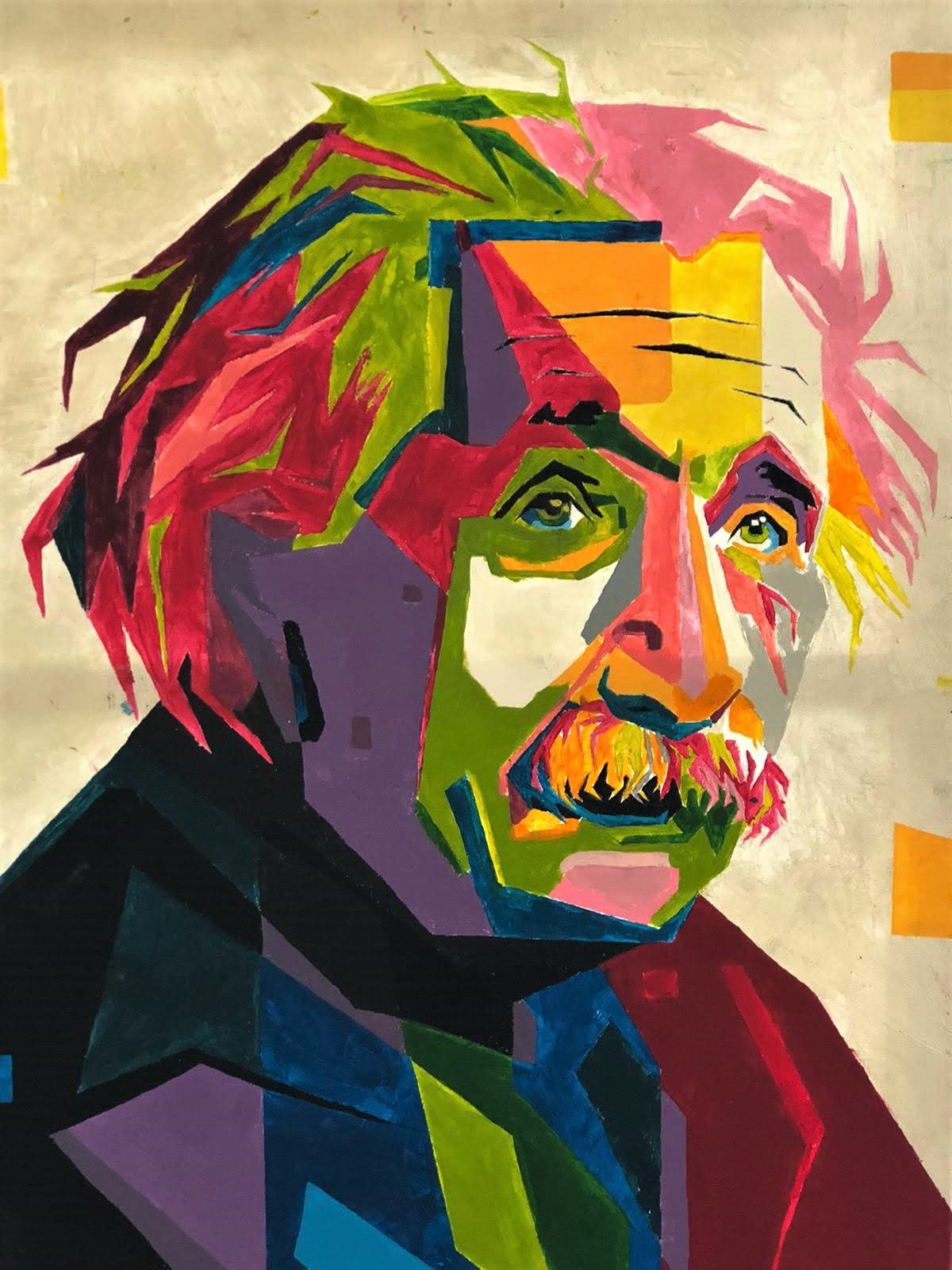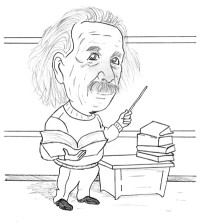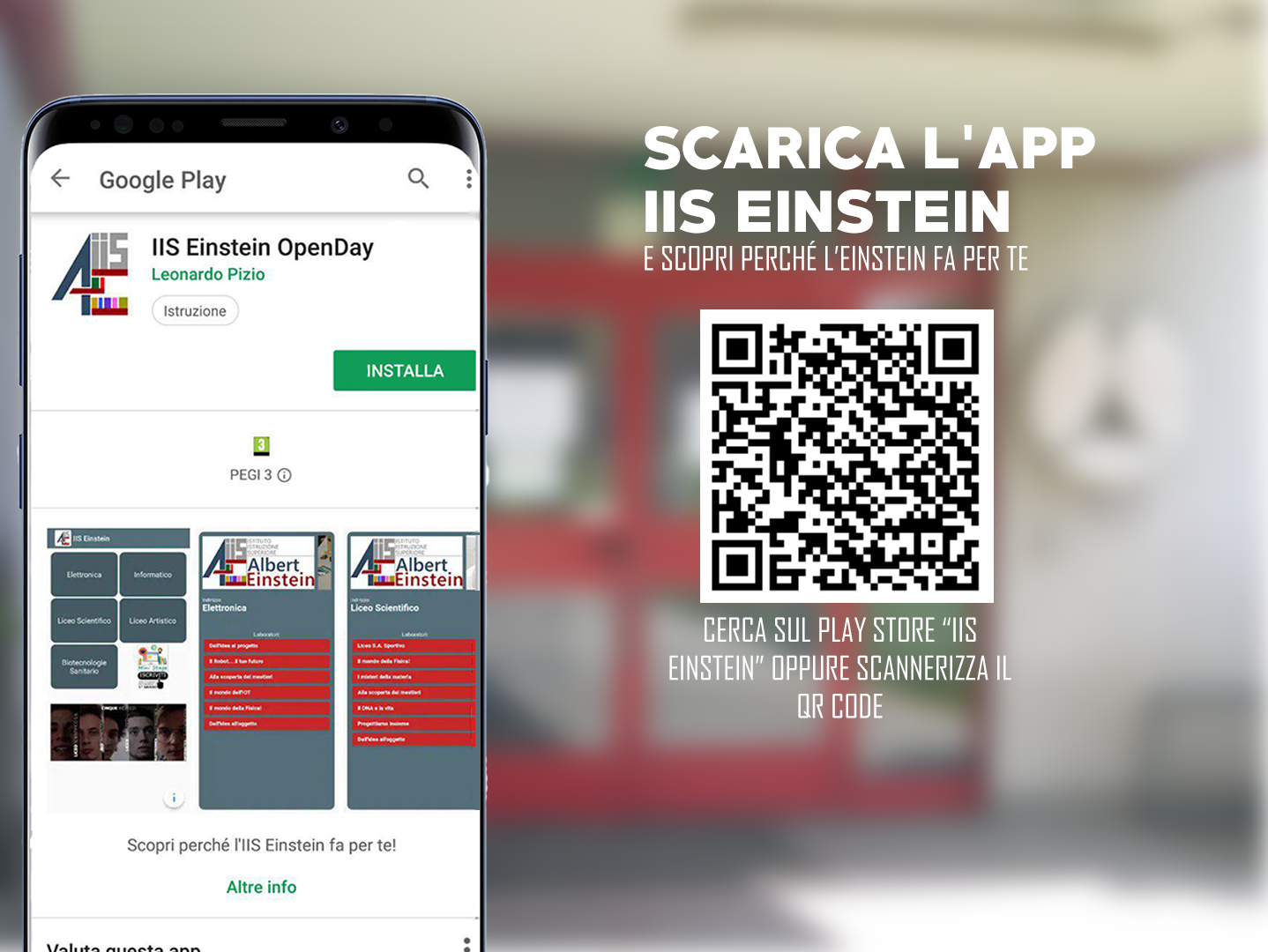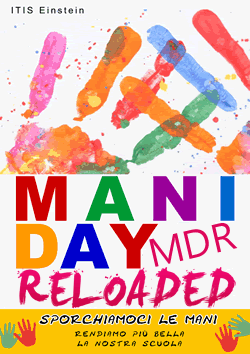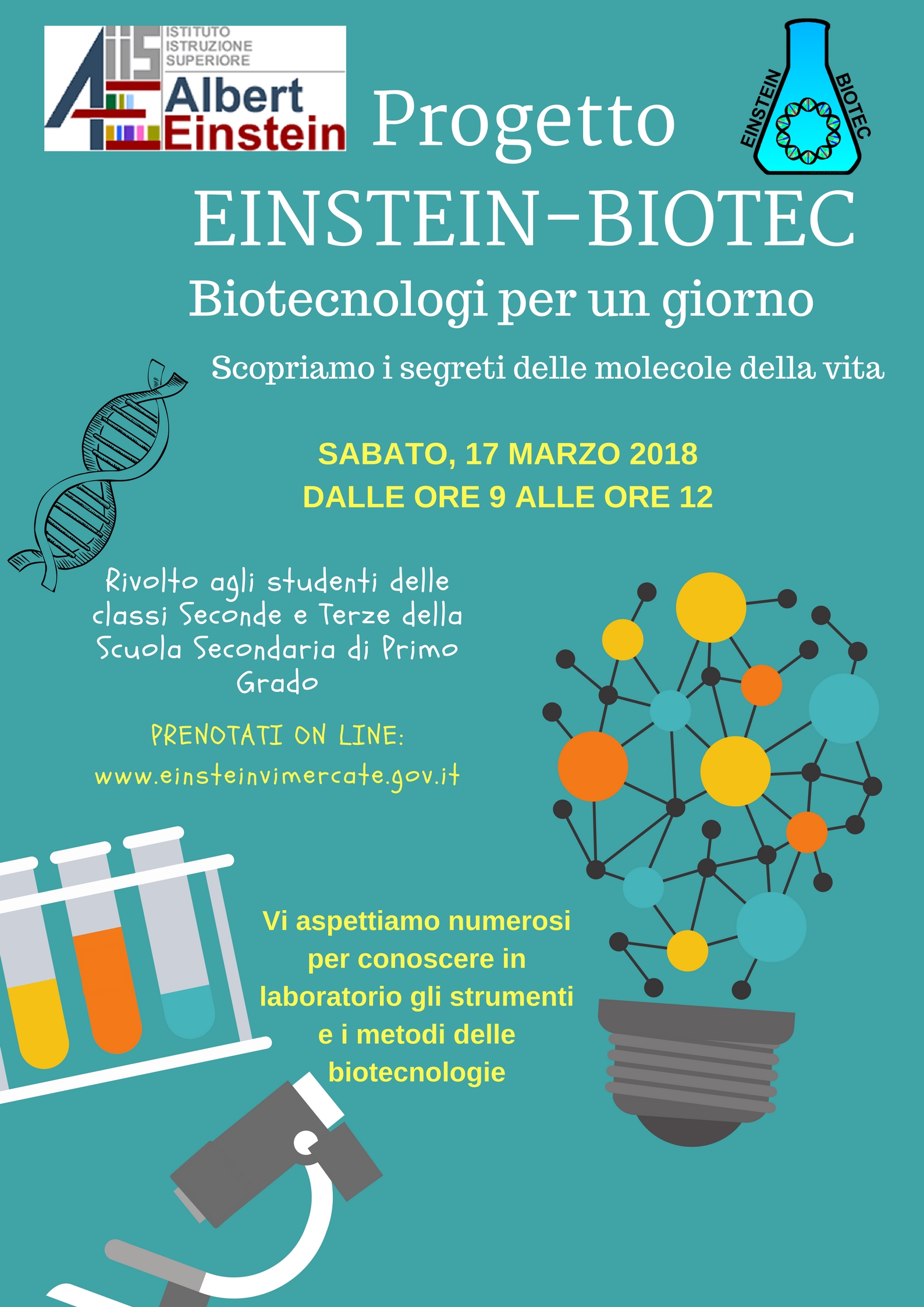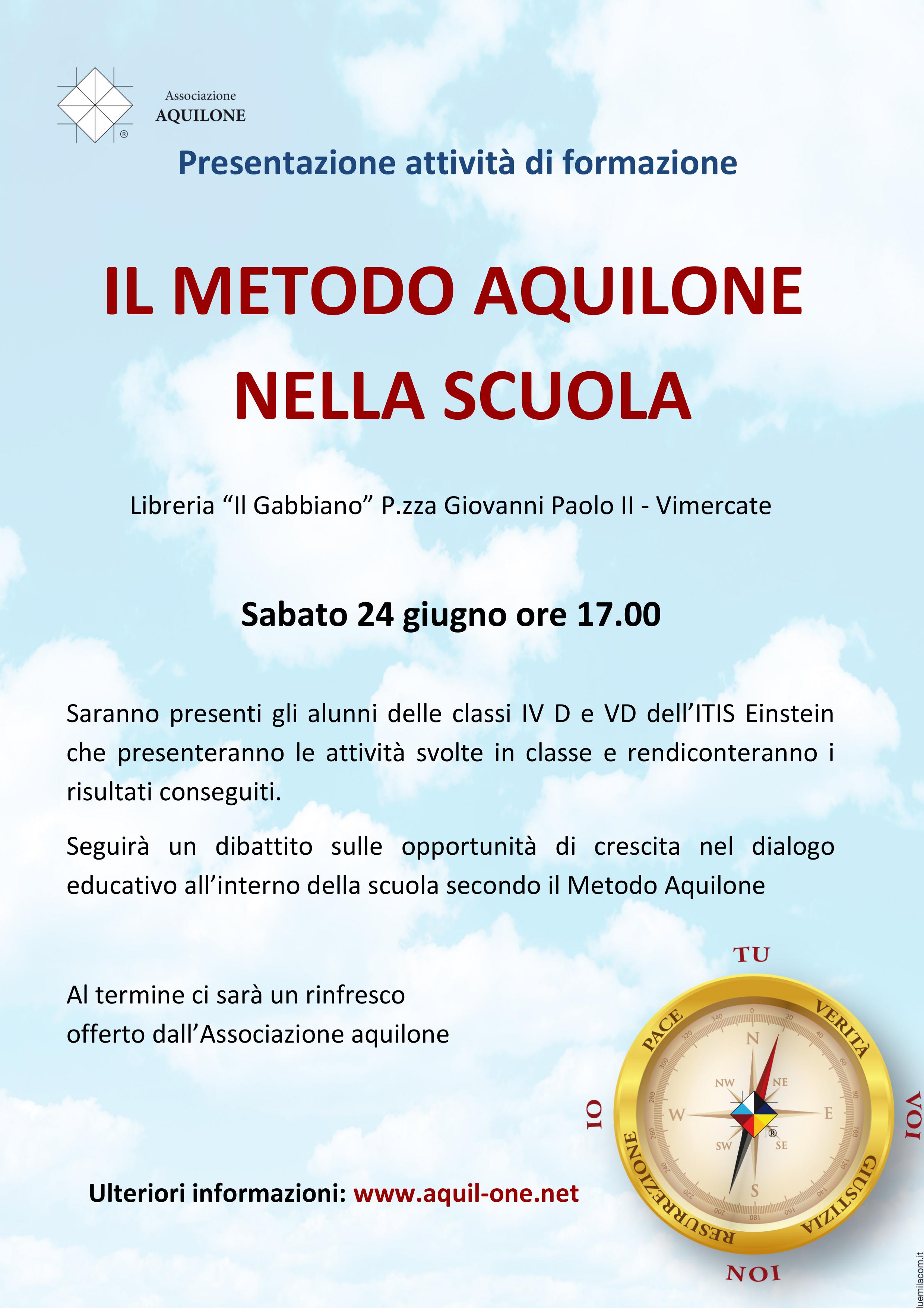A TUTTI I GIOVANI RACCOMANDO. L’importanza della letteratura da Alda Merini a una studentessa

A tutti i giovani raccomando
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
Alda Merini

La poesia e la letteratura sono, ma soprattutto sono state, il miglior modo di imparare e comunicare, dal concetto più concreto e scientifico al più astratto. La poesia è in grado di mostrarci anche il posto più lontano del mondo, come fa Marco Polo con “Il Milione”. Quando si legge la descrizione del palazzo del Gran Khan, lo si vede davanti agli occhi, non come se ci trovassimo seduti davanti ad un libro, ma in Cina al cospetto di un enorme e magnifico edificio. Non solo si vede con gli occhi, ma si sentono le stesse emozioni che si proverebbero se fossimo davvero presenti.
Oltre i luoghi, la letteratura può raccontare anche culture e ideali lontani. La sola lettura di testi sacri di religioni lontane dalla nostra può mostrare il pensiero e i comportamenti di popolazioni di cui altrimenti non sapremmo nulla, tranne gli stereotipi sociali. A diffondere gli ideali di una cultura, nel bene e nel male, sono anche libri politici, come “Il Principe” di Macchiavelli o il “Main Kampf” di Hitler. Questi libri, di fatto, sono stati scritti con questo scopo.

Ci sono anche nel difficile, astruso e apparentemente “iniziatico” linguaggio della scienza alcuni esempi di brillante prosa divulgativa, capaci di comunicare le scoperte e conoscenze scientifiche. Il più famoso divulgatore scientifico è Galileo Galilei che, pur di mettere tutti a conoscenza della teoria eliocentrica dell’universo, è stato incarcerato e costretto all’abiura. Altri libri come “Helgoland” di Carlo Rovelli spiegano la fisica quantistica a chiunque abbia la pazienza di leggerli. Anche in questi ultimi anni il giornalismo scientifico si è evoluto e si è posto alla portata di tutti, ad esempio con Focus e Focus Junior. Questo tipo di prosa ci permette di imparare e rendere disponibili a tutti queste conoscenze.
Letteratura e poesia sono anche protagonisti della formazione storica. Alcuni romanzi ci permettono di analizzare e ricostruire un periodo storico, come ha fatto Manzoni durante le ricerche sul ‘600 per “I promessi sposi”. Rappresentano anche il sentimento popolare, le preoccupazioni e le speranze comuni, ciò in cui le persone credono. Tutto ciò è fondamentale per ricostruire il sentimento del popolo in un determinato momento e contestualizzare gli eventi storici.

Ma a mio parere l’aspetto più interessante è quello introspettivo. Le produzioni della maggior parte degli autori che si studiano parlano di emozioni, dall’amore stilnovistico alle riflessioni sull’infelicità leopardiane, passando per il nazionalismo e il senso di appartenenza tipico degli autori di inizio ‘900. Il sentir parlare delle emozioni altrui ci permette in primo luogo di capire l’autore e in secondo luogo ci avvicina a noi stessi, facendoci capire e affrontare le emozioni che proviamo.
Nel complesso, una delle funzioni, e per me la più importante, della letteratura è quella di insegnare qualcosa agli uomini. È stata sfruttata per questo scopo da molti autori, a partire dal celeberrimo Dante Alighieri. Chi scriveva aveva un messaggio da dare o un concetto da insegnare e, nonostante i profondi cambiamenti nella società, è in parte ancora così. La letteratura è un insegnamento che si riceve se si è disposti a imparare da quello che si legge. Se, come dice Alda Merini, apriamo i libri con religione e non con superficialità. Religione intesa non nel suo aspetto spirituale, ma come sentimento di riverenza e rispetto e come disposizione dell’animo caratterizzata da devozione, timore e fiducia nei confronti della “sacra” superiorità del libro a cui ci approcciamo.

Per ricevere quello che la letteratura può darci dobbiamo rispettarla e capirla, ma soprattutto ringraziare chi l’ha scritta. Come suggerito dall’autrice non dobbiamo demonizzare un autore perché siamo costretti a studiarlo, ma ringraziarlo per ciò che ci dà. Gli autori, in un certo senso, lavorano per noi. Visitano luoghi e li raccontano, ci permettono di vederli senza doverci spostare; approfondiscono le emozioni e ce le spiegano secondo la loro sensibilità, senza lasciare a noi il gravoso compito di farlo; e, come ho imparato per esperienza diretta, hanno la capacità di trasportarci in un altro mondo pieno di meraviglie, lontano dalla triste realtà quotidiana.
Trovo che la poesia e la letteratura mi abbiamo ispirata, arricchita e fatta evadere. Non sento il peso di doverla studiare, ma il piacere di amarla e goderne. A seconda della necessità, mi fa riflettere o mi impedisce di pensare. Mi aiuta a scoprirmi e capirmi riconoscendomi in chi queste emozioni le ha vissute prima di me. La lettura mi ha ispirata a scrivere, a capire cosa ha mosso gli autori in questa direzione e a volermi sentire così anche io; mi ha portata a voler comunicare e lasciare il mio messaggio. Mi ha invogliata a voler affidare le mie parole alla carta per capirle meglio io e per comunicarle al mio prossimo. La letteratura mi ha fatta innamorare e la coscienza che tra pochi mesi smetterò di approfondirla con una guida mi spaventa e mi eccita allo stesso tempo. Perché in fondo il mio viaggio con la letteratura è appena cominciato.
Gaia Goldonetto