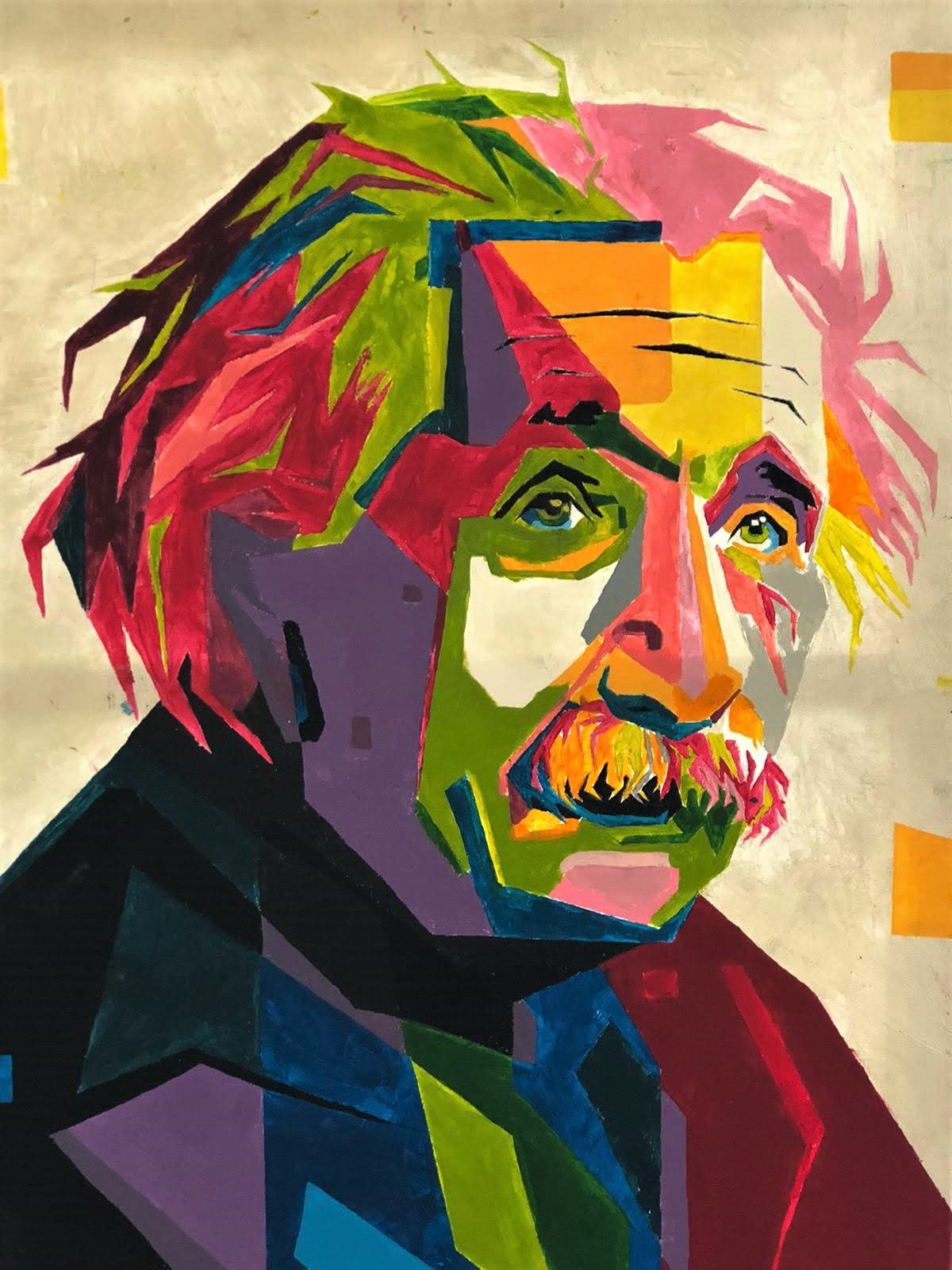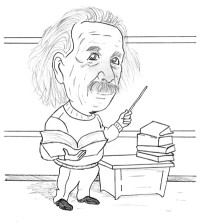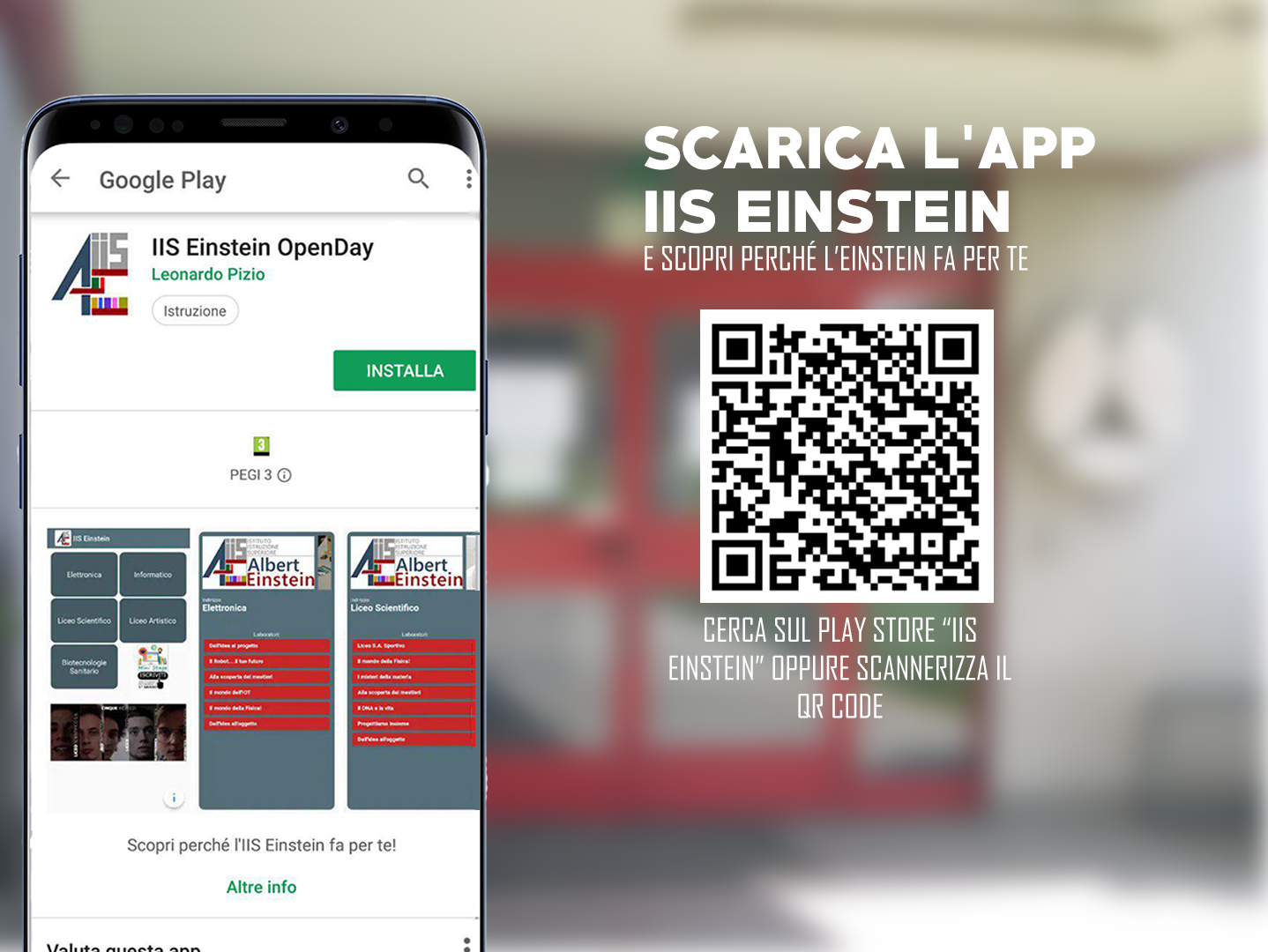I BAMBINI DI GAZA VOGLIONO RITROVARE IL LORO FUTURO. Intervista a Giuditta Brattini, operatrice umanitaria volontaria

A seguito di un lavoro di approfondimento sul conflitto Israelo-Palestinese svolto con la prof.ssa Viviana Di Marco, i ragazzi della classe 5 I hanno avuto l’opportunità di confrontarsi, grazie al contatto di un compagno, con Giuditta Brattini, cooperante volontaria per le associazioni Fonti di Pace e Gazzella. Queste organizzazioni di volontariato, grazie ai contributi di donatori, al 5X1000 e al finanziamento 8X1000 della Chiesa Valdese, sviluppano da vent’anni progetti in ambito sanitario-riabilitativo e di adozione a distanza di bambini feriti nella striscia di Gaza.
Per Giuditta lo scenario che oggi noi tutti vediamo oggi attraverso i media non è nuovo: operando da anni in questa zona critica del pianeta, ha saputo regalarci un punto di vista alternativo, diretto e trasparente su situazioni strazianti e su realtà che spesso vengono nascoste agli occhi del mondo. Questo è avvenuto tramite un confronto diretto con lei in modalità online e attraverso la visione di materiale video, raccolto a Gaza, che Giuditta ci ha mostrato.
Qui di seguito l’intervista fatta a Giuditta Brattini per consentire a tutti di incontrarla e conoscere dalle sue parole la situazione che il popolo palestinese vive ormai da tempo e che si è aggravata in modo netto dall’ottobre del 2023.
Buongiorno Giuditta, da quanto tempo ti rechi nella striscia di Gaza? Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a diventare volontaria?
La mia attività come volontaria in Palestina è iniziata nel 2003. Essere volontaria è una scelta di agire quotidiano che mi permette di raccogliere i bisogni, comprendere le difficoltà della popolazione e insieme trovare le soluzioni sostenibili. Non mi obbliga a rispondere a una struttura di Organizzazione non governativa, con tanto di apparato amministrativo e “professionisti” stipendiati, che solitamente viene finanziata dai Governi o dall’Unione Europea, costringendole a rispondere ai criteri dei “donatori” e non alle esigenze reali della popolazione. Oggi viviamo di “un’economia di guerra” e una parte di questa è destinata all’aiuto umanitario che, indipendentemente dalla volontà degli operatori, si intreccia con i processi che alimentano gli stessi conflitti in azioni funzionali ai disegni e interessi politici di un determinato scenario geopolitico.
Quali progetti porti o portavi avanti a Gaza con le associazioni?
Il mio lavoro di Operatrice Umanitaria Volontaria, per 20 anni, è con l’Associazione Gazzella che si occupa di bambini feriti e della loro salute che vivono nella striscia di Gaza. Si tratta di adozioni a distanza. Nel corso delle missioni raccolgo le informazioni sulle loro condizioni di salute e le trasferisco agli adottanti. In questa attività c’è il supporto dei partners locali che danno il loro sostegno logistico. L’adozione a distanza di bambini/e feriti è anche una forma di denuncia, perché i bambini sono i più esposti durante le aggressioni armate; spesso sono in strada a giocare o a scuola.
Per l’Associazione Fonti di Pace seguo poi il progetto di riabilitazione per bambini e adulti con disabilità. Un progetto finanziato con l’8×1000 dalla Chiesa Valdese. Per lo sviluppo del progetto ci si avvale di un partner locale, il Palestinian Medical Relief Society. Il progetto è rivolto ai disabili e alle persone che li seguono nella vita quotidiana e solitamente sono le madri. Le donne sono l’ossatura della famiglia. I padri sono spesso senza lavoro o con lavori saltuari. Nel progetto sono previsti anche i servizi della psicologa a supporto sia dei disabili, sia dei famigliari che li assistono. Spesso infatti la comunità colpevolizza la madre per la disabilità del figlio.
Abbiamo riscontrato quanto influiscono le carenze strutturali sanitarie sul deficit di un bambino. La causa è l’assedio imposto da Israele dal 2007 alla popolazione della striscia di Gaza; mancano attrezzature sanitarie per la prevenzione e cura, mancano farmaci. Così le madri, nel periodo della gravidanza, non possono accedere a visite di controllo, assumere medicinali se necessario e al momento del parto una carenza sanitaria, risolvibile facilmente in altre situazioni, può comportare dei danni permanenti al bambino.
Ricordo l’ultimo incontro con i famigliari dei bambini con disabilità che avevano chiesto di continuare il progetto per non far perdere ai loro figli i benefici fino ad allora avuti!
Nel 2020, grazie ai donatori abbiamo rinnovato due Dental Clinic nei distretti sanitari pubblici di Shaty e El Burej con l’acquisto della poltrona dentista “riunito”, compressore, amalgatore e arredo. Stavamo sostenendo i servizi con l’acquisto di materiali sanitari per le cure dentali, ma oggi, causa l’aggressione israeliana in corso, i progetti sono sospesi.

Come hai visto evolversi la situazione a Gaza?
Dal 2007 Israele ha imposto un assedio sulla striscia di Gaza. Ha privato la popolazione della libertà di movimento e il passaggio di persone per e da Gaza è consentito soltanto per “casi umanitari ed eccezionali”. Ha imposto il controllo sull’anagrafe della popolazione, sulle entrate economiche, sulle attività amministrative, sul transito delle merci e il sistema doganale, sulle telecomunicazioni, l’acqua e la rete fognaria. L’elettricità viene erogata per 6-8 ore al giorno. A Gaza la popolazione ha accesso a meno di un quarto dei beni rispetto al 2005 e Israele permette l’entrata soltanto di quei prodotti che sono “essenziali alla sopravvivenza”, limitandone anche il numero.
Un assedio che comporta l’impossibilità ad accedere a cure adeguate; una crisi dell’educazione scolastica, tra sovraffollamento e mancanza di strutture, personale e risorse, unitamente a una crisi del benessere psicofisico della popolazione, soprattutto tra i minori affetti da disordini post-traumatici. A Gaza il 70% sono rifugiati del 1948 e del 1967 e vivono di aiuti umanitari.
Da parte di Israele il lungo assedio e il controllo sulla Striscia di Gaza sono motivati da ragioni di sicurezza verso i gruppi armati palestinesi presenti nella Striscia. Tuttavia, per esperienza diretta, posso dire che a pagare le conseguenze di tale politica sono i civili, privati del legame diretto con il mondo e dell’esercizio dei diritti universali.
Negli ultimi due anni la popolazione esprimeva sentimenti di disperazione e di sconforto. Chiedeva la fine degli attacchi armati ed era in attesa di una risoluzione del conflitto e della fine dell’assedio che la teneva prigioniera. Il 7 ottobre non era del tutto “inaspettato”.
Ci racconteresti una tua giornata nella Striscia?
Il senso delle mie giornate a Gaza era dato, principalmente, dall’incontro con i “miei” bambini e le loro famiglie. Al mio arrivo a Gaza, in accordo con i collaboratori locali, preparavo il calendario delle attività. Solitamente il lavoro iniziava alle 8am e terminava verso le 4pm. Quando tornavo negli alloggi, facevo un pranzo-cena. Ma non arrivavo mai con lo stomaco vuoto. Verso le 11am era prassi uno spuntino con falafel e ful, una crema di fave! Per raggiungere i bambini mi spostavo sul territorio con un mezzo del partner locale. Questo per quanto riguarda le visite ai bambini feriti o con disabilità del progetto associazione Gazzella.
Per il monitoraggio del progetto di riabilitazione ai disabili, progetto Associazione Fonti di Pace, arrivavo a Khan Yunis dove c’era il Centro di Riabilitazione, ora bombardato, e lì incontravo parte degli assistiti con le madri. Assistevo alle prestazioni di riabilitazione, ma partecipavo anche agli incontri tra le madri, che fanno assistenza al disabile, e la psicologa. Altre giornate erano organizzate per fare visita, con il personale addetto alla riabilitazione, ai disabili che causa la loro condizione non potevano spostarsi e che ricevevano i servizi a domicilio. Altre giornate venivano impegnate a monitorare i servizi delle due cliniche dentali che sono state allestite nei distretti sanitari di Shaty Camp e El Burej Camp, oggi non operative e colpite dai bombardamenti. Spesso, nel corso della giornata, c’erano bombardamenti, giustificati da Israele contro i combattenti, ma che di fatto impaurivano e destabilizzavano la vita quotidiana della gente.

Come vivono i ragazzi della nostra età a Gaza?
I giovani a Gaza sono assediati e vivono costantemente il desiderio di potersi spostare. Per tanti il sogno è andare a Gerusalemme e nei Territori Occupati a trovare parenti e amici. Non vogliono andarsene dalla striscia di Gaza e abbandonare ciò che hanno, ma vorrebbero poter studiare all’estero, fare esperienza e tornare per migliorare le condizioni della propria famiglia, del loro paese. Hanno un profondo legame con la storia della loro terra che vorrebbero far conoscere. I giovani sono cresciuti sotto i bombardamenti e un ragazzo della vostra età a Gaza ha già vissuto almeno 4 aggressioni armate. È normale che siano ansiosi, vivono in un quotidiano fatto di attacchi armati, nel terrore di perdere la vita o quella dei loro cari e amici. I giovani gazawi utilizzano molto i social per comunicare e stabilire relazioni. Ma i contatti relazionali-virtuali, che maturano con l’utilizzo dei social, allontanano i giovani dalle attività sociali. I momenti di svago sono pochi, mancano cinema e teatri e capita di incontrare giovani sul lungo mare o seduti nei pochi centri commerciali o coffee pub. Sono pochi anche i centri ricreativi, è più facile vedere giovani giocare a calcio in strada. La dispersione scolastica è alta per mancanza di risorse economiche, la disoccupazione è al 60%. Ma le strutture scolastiche a Gaza non mancano. Secondo i dati del Ministero Istruzione-Educazione di Gaza ci sono 803 scuole, così distribuite: 448 scuole governative, 288 scuole UNRWA e 67 scuole private. Le università sono 4 con diversi dipartimenti. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la Striscia di Gaza è un’area densamente popolata. Vivono 2 milioni e 300 mila persone su 365kmq, concentrate soprattutto nei campi profughi e nella città di Gaza City, circa 7.000 civili per kmq. I giovani di Gaza non si fanno programmi, tutto dipende dalla situazione del momento e dalle circostanze, ma hanno tanti sogni.
Come vivono la guerra entrambe le parti? Ci sono parti contro la guerra?
Non possiamo parlare di guerra. Nell’attuale scenario ci troviamo di fronte all’esercito di Israele che è tra le prime 20 potenze militari del mondo, con a disposizione sofisticate tecnologie, un equipaggiamento militare con una vasta gamma di armi. Dall’altra parte razzi, per lo più intercettati dagli Iron Dome israeliani, e pochi armamenti. Quella tra Israele e Hamas non è una guerra per una questione di asimmetria. Secondo i dati aggiornati al 4 aprile scorso, nella striscia di Gaza si contano 33.545 morti e 76.094 feriti. Save the Children dichiara che in 6 mesi di attacchi un bambino è morto ogni 15 minuti. I bombardamenti sono continui, la popolazione sfollata, oltre 1milione e 600mila, si è spostata a Sud della Striscia di Gaza alla ricerca di una salvezza, di un luogo sicuro che non è garantito. I civili cercano di sfuggire agli attacchi via cielo, via mare e via terra dell’esercito israeliano. Raid aerei hanno raso al suolo case seppellendo al loro interno famiglie intere. In sei mesi di attacchi la popolazione è allo stremo e sull’orlo di una crisi umanitaria senza precedenti; mancano cibo e acqua. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che Gaza sta affrontando “livelli catastrofici di insicurezza alimentare”, con il rischio di carestia che “aumenta di giorno in giorno”. Di 36 ospedali solo 6 sono ancora parzialmente operativi e il sistema sanitario è al collasso. La diffusione di malattie infettive tra gli sfollati nelle tendopoli e nelle scuole sta aggravando la già compromessa situazione igienico-sanitaria, che vede una diffusione di infezioni intestinali e respiratorie, malattie contagiose, vaiolo, meningiti, epatite. “C’è il rischio che muoiano più persone a causa di malattie che a causa dei bombardamenti a Gaza se il sistema sanitario del territorio non viene rimesso in piedi rapidamente”, ha dichiarato un portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Gli aiuti umanitari non arrivano a Gaza e quelli che entrano nella striscia sono soggetti ad attacchi da parte dell’esercito israeliano. È di questi giorni l’attacco a un convoglio umanitario della Ong World Center Kitchen che ha causato la morte di 7 operatori.
L’assalto di Hamas dello scorso 7 ottobre ha causato circa 1.200 vittime e 253 civili sono stati presi in ostaggio. Secondo le stime ufficiali, attualmente nella Striscia di Gaza sono rimasti circa 130 ostaggi. Ci sono manifestazioni in Israele per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma anche gruppi di pacifisti israeliani che chiedono la fine dei bombardamenti. Alcuni Paesi Arabi e 24 stati dell’America Latina e dei Caraibi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui chiedono un cessate il fuoco immediato. Da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea c’è il pieno sostegno all’operato di Israele. Ma nelle strade di tutto il mondo centinaia di migliaia di persone protestano contro l’aggressione a Gaza. Questa è la vera e forte voce che sostiene il popolo di Gaza e che può fare la differenza.
Come vivi tu a livello personale/psicologico questa situazione?
Sono rientrata in Italia lo scorso 3 novembre, ma non ho mai lasciato Gaza, i “miei” bambini, le persone che conosco, i luoghi dove per 20 anni ho costruito e sviluppato progetti. Vedere le immagini dei massacri, i bambini stesi sui pavimenti degli ospedali in attesa di cure, le immagini di distruzione della struttura sanitaria del Palestinina Medical Relief Society dove alloggiavo durante le mie missioni e dove tanti civili venivano per le cure e la prevenzione; la devastazione dello Shifa hospital dove ero di “casa” al pronto soccorso, nel reparto di maternità e neonatale e dove abbiamo fornito letti, incubatrici, ecografi grazie al sostegno dei nostri donatori… ecco, è doloroso. Mi dà la forza pensare ai “miei” bambini che stanno lottando e resistendo. Quindi il mio impegno deve essere grande e diffuso.

Cos’è Hamas e che ruolo ha oggi a Gaza?
Hamas in arabo vuol dire “entusiasmo”. È un Movimento di Resistenza Islamico fondato nel 1987. Hamas è considerata un’organizzazione terroristica da Israele, Unione Europea, Usa, Canada, Giappone. Altri Paesi, come Australia e Regno Unito, considerano solo la sua ala militare, le brigate Ezzedin al-Qassam, come organizzazione terroristica. Lo scorso mese di febbraio il sottosegretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, ha dichiarato: “Per noi Hamas non è un gruppo terroristico, come sapete, è un movimento politico”. Hamas è un’organizzazione complessa composta da diversi organi con funzioni politiche, militari e sociali, come lo sono anche altre fazioni politiche palestinesi. Nel 2006 Hamas ha vinto le elezioni politiche nei Territori Occupati e nella striscia di Gaza. Una vittoria elettorale non riconosciuta dall’Europa, Stati Uniti e Israele che ha portato in carcere gli eletti di Hamas che stavano nei territori occupati. Hamas ha tenuto il controllo nella sola Gaza e nel 2007 Israele l’ha messa sotto assedio. Il Movimento di Resistenza Islamico è sostenuto finanziariamente da alcuni Paesi arabi: Qatar, Siria, Iran. Negli ultimi 17 anni Hamas ha gestito nella striscia di Gaza programmi sociali, sostenuto e ampliato strutture sanitarie ed educative guadagnando popolarità nella società palestinese.
Oggi il progetto di Hamas, dopo la revisione, nel 2017, dello statuto costitutivo, è quello di costringere lo Stato ebraico a ritirarsi dai territori occupati nel 1967 per costituire uno Stato di Palestina.
La sfida di Hamas oggi è quella di essere riconosciuto come soggetto politico accreditato alle trattative.
La popolazione di Gaza cosa pensa di Hamas?
Dal 7 ottobre scorso la propaganda israeliana vuole Hamas che si fa scudo dei civili di Gaza. Ma la realtà è altra: i combattenti di Hamas conoscono capillarmente il territorio della striscia di Gaza, punti di forza e fragilità, mentre Israele fin dalle prime ore del 7 ottobre scorso ha bombardato indiscriminatamente il territorio, mercati, scuole, ospedali, abitazioni, massacrando i civili alla ricerca “cieca” di obiettivi militari. Il recente sondaggio, dello scorso mese di gennaio, condotto dal Palestinian Center for Policy and Survey Research (Centro Palestinese per le Politiche e le Ricerche) in Cisgiordania e Gaza, ha rivelato che il sostegno al Movimento di Hamas è ancora forte: “Il sostegno all’offensiva di Hamas del 7 ottobre rimane alto, quanto tre mesi fa”. Quasi il 60% degli intervistati di Gaza ritiene che “Hamas manterrà il controllo della Striscia di Gaza anche in futuro”. Secondo il sondaggio, “la soddisfazione nei confronti di Hamas resta molto alta. Al contrario, quella nei confronti di Al Fatah è molto bassa”.
Qual è la situazione delle donne in Palestina? Come era prima della guerra?
Sono diversi i fattori di discriminazione delle donne in Palestina, a partire dalla predominanza di leggi e legislazioni obsolete e dall’assenza di una legge sulla protezione della famiglia e di un sistema di protezione completo per le vittime di violenza di genere. Un impatto negativo sulla vita di tutti i palestinesi, in particolare delle donne e delle ragazze. L’Osservatorio nazionale per la violenza contro le donne, di cui fanno parte ufficialmente 18 ONG e istituzioni governative, sta dando un importante contributo allo sviluppo di piani per combattere la violenza contro le donne, frutto del patriarcato prodotto del pensiero maschilista dominante. Ma se questo vale nella “quotidianità” delle donne colpite da diseguaglianza sociale e di genere, gli effetti più drammatici le donne li subiscono in tempo di aggressioni armate, quando vengono separate dai loro compagni e dai figli. Devono fare i conti con povertà e altre sofferenze a volte non raccontate, ma che storicamente sono parte integrante di tutti i conflitti. Nel corso degli ultimi 76 anni, l’occupazione israeliana ha causato sofferenze e determinato una condizione particolare per le donne palestinesi, che per generazioni hanno affrontato avversità, stress e paura. Anche per questo la loro condizione le vede escluse e intrappolate in un ciclo di violenze dirette e indirette. La donna palestinese deve subire l’aggressione di Israele e contemporaneamente deve confrontarsi con una società conservatrice e patriarcale. Sofferenze che portano depressione e profondo senso di disperazione. Oggi a Gaza le donne insieme ai bambini costituiscono circa il 70% dei morti e le donne uccise appartengono a tutte le categorie sociali: giornaliste, medici, dipendenti delle Nazioni Unite e membri della società civile. L’ONU ha stimato che ogni ora vengono uccise due madri e ogni due ore ci sono sette vittime donne. Ho conosciuto donne e ragazze che, da quando sono nate, hanno affrontato prima di tutto il dramma e la violenza dell’occupazione israeliana, che le ha costrette a vivere senza genitori, marito e figli.

Le informazioni internazionali e nazionali su questa guerra rappresentano la realtà?
Nella Striscia di Gaza il giornalismo sta morendo, anche fisicamente. Dall’inizio dell’aggressione, il 7 ottobre scorso, sono 142 i giornalisti assassinati. Un crudele massacro sta avvenendo e nello spazio pubblico non si riesce a discuterne. Mancando i giornalisti, non c’è la narrazione dei fatti che ci possa quindi sottrarre da supposizioni, sospetti. Il “pensiero comune” trova spazio con accuse di presunte complicità con i “terroristi di Hamas” o addirittura di antisemitismo. I giornalisti morti sono operatori dell’emittente Al Jazeera, free lance, ragazzi e ragazze gazawi laureati alla facoltà di comunicazione. Storie di giovani che rimarranno sconosciute, ignorate o dimenticate perché è mancata l’indignazione dei loro colleghi di altri Paesi. Solo la presenza di giornalisti-reporter può documentare ciò che avviene a Gaza, pena subire l’univoca informazione delle veline dell’esercito e governo israeliano. Lo abbiamo visto il 7 ottobre scorso quando informazioni diverse si sono rincorse sui fatti del giorno accaduti nei Kibbutz: decapitazioni di bambini, violenze, salvo smentite successive da parte degli stessi giornalisti dei giornali Haaretz, The Forward e New York Times. Nei mesi scorsi, l’Ordine Internazionale dei Giornalisti ha per ben due volte chiesto a Israele di poter arrivare nella striscia di Gaza, ma ha ricevuto il rifiuto della Corte Suprema israeliana. Questo fatto mina alla base il diritto all’informazione. Gli unici ammessi nel territorio di Gaza dopo il 7 ottobre sono “embedded” all’esercito israeliano. Questo implica accettare condizioni, come presentare il materiale ai militari prima della pubblicazione e non avere autonomia di movimento. Gli unici quindi che possono raccogliere informazioni e raccontare con le immagini quello che succede dentro la Striscia di Gaza sono i giornalisti che abitano sul territorio. Documentare-informare da Gaza vuol dire mettere a rischio la propria vita e anche quella dei familiari. I reporter palestinesi lavorano in condizioni difficili, sotto le bombe e spesso senza elettricità, fatto questo che rende difficile l’invio delle informazioni. I resoconti dei giornalisti di Gaza sono preziosi non solo perché fanno arrivare al mondo le voci degli abitanti della Striscia, ma anche perché sono uno strumento di resistenza, un modo per le persone di ritrovare una dignità e un senso in mezzo all’orrore che stanno vivendo. Non ultimo, in violazione al diritto all’informazione, il parlamento di Tel Aviv ha approvato, nei giorni scorsi, una legge che conferisce al governo la facoltà di chiudere le “voci” giornalistiche ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Nel mirino è l’emittente di Al Jazeera, una testata giornalistica internazionale che da anni fornisce notizie e informazioni in particolare sul mondo arabo, ma non solo, e che segue da vicino le vicende israelo-palestinesi. Al Jazeera potrebbe essere la prima di una lunga lista.
Hai ancora contatti diretti con alcuni abitanti di Gaza?
Alcuni contatti con i partner locali dei progetti sono attivi, ma con molte difficoltà, perché dal 7 ottobre scorso Israele ha interrotto le forniture di elettricità e bloccato l’afflusso del carburante utile per i generatori. I contatti avvengono con scambi di messaggi WhatsApp, mi aggiornano sulla situazione e la loro condizione. Dei bambini inseriti nei progetti, sia di riabilitazione che di adozione a distanza, fino ad ora non abbiamo notizie. È probabile che la maggior parte siano sfollati nelle tendopoli o nelle scuole Unrwa. I nostri collaboratori non sono in grado di raggiungerli, causa i continui attacchi e l’esercito israeliano è presente sul territorio con carri armati e cecchini. Quindi anche gli spostamenti sono difficili e pericolosi.
Oltre a Gaza puoi descriverci la situazione oggi in Cisgiordania?
Con la Risoluzione Onu n. 181 del 1948 è stato creato lo Stato di Israele e si è sancita così la spartizione del territorio della Palestina storica attribuendo il 56% del territorio a 600 mila ebrei e il rimanente 44% a 1.250.000 Palestinesi, e Gerusalemme sotto tutela internazionale.
Come conseguenza 700 mila palestinesi sono stati espulsi dalla loro terra e dalle loro case, anche con la forza e il terrore. Lo storico israeliano Ilan Pappe, riferendosi ai fatti successivi alla Risoluzione Onu 181, parla di pulizia etnica.
Oggi abbiamo quasi 5 milioni di rifugiati palestinesi dislocati in 58 campi profughi tra la Giordania (1.967.414), Siria (467.417), Striscia di Gaza (1.172.929), Cisgiordania (771.143), Libano (421.993).
La risoluzione Onu n. 194 del dicembre 1948 ha riconosciuto ai rifugiati il Diritto al Ritorno alle loro case, ma il Diritto al Ritorno resta ancora oggi per i Palestinesi una questione irrisolta.
La “Guerra dei sei giorni” nel 1967 e la vittoria di Israele sulla coalizione di paesi arabi ha definito un nuovo assetto territoriale in Cisgiordania a favore di Israele. Da allora Israele sta continuando, attraverso l’espulsione della popolazione palestinese, a occupare territorio, monopolizzando le risorse dell’acqua e i terreni fertili. In Cisgiordania sono oltre 200 gli insediamenti costruiti sulla terra destinata ai Palestinesi. Vivono circa 700 mila coloni israeliani. Quotidiane sono le aggressioni armate alla popolazione palestinese sia da parte dell’esercito israeliano che dei coloni. Nell’anno 2023 i morti sono stati 467, di cui 259 uccisi dopo il 7 ottobre e 12.566 i feriti. I prigionieri oltre 7.000, di cui 2.070 in “detenzione amministrativa”, un istituto che prevede la carcerazione a tempo indeterminato, senza processo e senza possibilità di difendersi da prove tenute segrete (dati della Ong israeliana per i diritti umani Ha Moked). Di questi prigionieri, circa 700 sono i minorenni sottoposti alla detenzione amministrativa.
Un muro lungo 730 chilometri e la presenza di check point separano le città palestinesi della Cisgiordania, dove vivono circa 3.250.000 persone, di cui il 50% sono bambini. Questa realtà impedisce il libero movimento con gravi implicazioni sulla vita quotidiana.

Anche in Palestina, oltre che in Ucraina, si stiano usando armi non riconosciute e non approvate dalla convenzione internazionale sulle armi non convenzionali. Puoi spiegarci come Israele riesca a continuare a usare a Gaza bombe illegali come quella al fosforo?
Già nel corso dell’aggressione Piombo Fuso, 27.12.2008-18.1.2009, Israele aveva utilizzato bombe al fosforo bianco, arma letale, devastante e proibita. Diverse le testimonianze, prove e denunce, ma non sono mai stati aperti procedimenti nei confronti di Israele e applicate sanzioni. Chi sta negli ospedali durante le aggressioni si trova a esaminare le ferite che deve curare. Nell’aggressione in corso, i medici chiedono di fare luce sull’utilizzo di alcuni armamenti. Devono curare ustioni presenti su oltre il 50% corpo, pur in assenza di altre significative ferite; questo elemento indica l’uso di bombe progettate per incendiarie o distruggere con il fuoco. Il ferito per l’utilizzo di bombe al fosforo bianco presenta bruciature delle parti di tessuto molle e poi necrosi ossea. Il fosforo bianco prende fuoco spontaneamente a contatto con l’aria e, successivamente all’esplosione, si vaporizza nell’ambiente sotto forma di gas, e può quindi essere inalato, provocando effetti devastanti per la salute dell’uomo e sull’ambiente. A Gaza il diritto internazionale viene calpestato perché Israele lancia attacchi indiscriminati contro i civili con l’utilizzo di bombe incendiarie proibite e non rispetta il Protocollo III della Convenzione di Ginevra del 1980. Alcuni feriti presentano nette e orribili amputazioni dovute all’uso dei missili R9X Hellfire. Un’arma relativamente nuova nell’arsenale americano, venduta a Israele, e praticamente unica. Non contiene alcun tipo di esplosivo ma è munita di lame rotanti che vengono scagliate al momento dell’esplosione. La bomba a fléchette al momento dell’esplosione rilascia migliaia di freccette d’acciaio, di circa 3cm., che al contatto col corpo penetrano al suo interno, producendo lesioni gravi. In alcuni casi, possono penetrare così profondamente da passare attraverso le ossa. È forse la bomba che da più anni l’esercito israeliano utilizza contro i civili di Gaza e della Cisgiordania.
A oggi, l’esercito israeliano ha attaccato la striscia di Gaza con oltre 60.000 tonnellate di bombe. Una bomba atomica a “rate”. Il silenzio della Comunità Internazionale sull’utilizzo da parte di Israele di bombe non convenzionali gli ha dato il semaforo verde per continuare.

I paesi confinanti come sono influenzati dal conflitto in atto? La loro economia viene intaccata da esso?
L’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre non ha visto delle ferme condanne dai Paesi Arabi, ma solo auspici di una generica cessazione della violenza. La situazione è piuttosto complessa e articolata. Nello scenario politico si deve tenere presente che nel 2020 Marocco, Emirati Arabi e Bahrein hanno firmato con Israele gli Accordi di Abramo e la questione palestinese è rimasta fuori dagli Accordi. L’Arabia Saudita da tre anni viene indicato come il prossimo Paese a “normalizzare” i propri rapporti con Israele; Egitto e Giordania si sono limitati a denunciare i gravi rischi di una possibile escalation militare. Qatar, Kuwait e Lega Araba (organizzazione che riunisce alcuni paesi del Nordafrica e quelli della Penisola Araba) hanno invece indicato in Israele e nelle sue politiche oppressive verso i palestinesi la causa dell’attacco del 7 ottobre. L’ago della bilancia resta il Qatar, da sempre sostenitore del Movimento di Resistenza Islamico che sta al momento tenendo le redini degli incontri per un cessate fuoco. Il Qatar da sempre mantiene rapporti e finanzia Hamas, ma ha anche relazioni diplomatiche-politiche con Israele. La perdita di vite umane, l’estensione della distruzione di infrastrutture e abitazioni, la riduzione della filiera della produzione hanno determinato effetti devastanti per l’economia Palestinese. E la povertà già presente è destinata ad aumentare, tutto dipende dall’intensità e dal protrarsi del conflitto. Quale sarà l’esito l’economico lo possiamo in parte già vedere e ne sono coinvolti i Paesi dell’area mediorientale e non solo. L’impatto significativo del conflitto deriva innanzitutto dalla rilevanza economica rappresentata dal petrolio e dal gas, di cui l’area mediorientale è tra le più ricche al mondo. Quindi l’Europa, come il resto dei Paesi dipendenti dalle forniture di petrolio-gas dal Medioriente, si trova a dover affrontare nuove strategie energetiche dovendo prendere in considerazione la possibilità di una espansione delle energie rinnovabili. Altra situazione che contribuisce alla crisi economica è la presenza degli Houthi dello Yemen che con i loro interventi armati rallentano e in alcuni casi bloccano nel Mar Rosso le navi mercantili dirette in Israele. Questa azione degli Houthi è una forma di ritorsione e pressione contro i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti, con la missione navale internazionale Prosperity Guardian formata da numerosi Paesi tra cui l’Italia, stanno operando per garantire sicurezza e libertà di navigazione nel Mar Rosso, per il normale funzionamento del commercio globale. Ritardi nell’arrivo delle navi-merci oppure l’obbligo di dover circumnavigare l’Africa per arrivare in Europa ha portato come conseguenza l’aumento sul mercato dei prezzi dei beni di consumo. In Israele gli interventi militati hanno dato stimolo all’incremento della spesa pubblica nel campo militare. Il governo israeliano è stato costretto ad aggiungere alle circa 170.000 unità regolarmente arruolate, più di 350.000 riservisti sottraendoli quindi alla forza lavoro. Ciò comporterà a breve che molti settori dell’economia israeliana si troveranno a fare i conti con una carenza di forza lavoro. Inoltre, non va dimenticato che una parte dei lavoratori nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, circa 18.000, era rappresentata da palestinesi con permessi di lavoro dalla striscia di Gaza, e che oggi non sono più attivi.
Ma nel disastro economico che il conflitto sta portando ci sono altri elementi di squilibrio da tenere presenti: climatici e migratori. Lo studio pubblicato lo scorso mese di gennaio “A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict”, evidenzia che “Le emissioni previste per i primi 60 giorni della guerra Israele-Gaza erano maggiori delle emissioni annuali di 20 singoli Paesi e Territori. Lo studio si basa però solo su una parte di attività ad alta intensità di carbonio ed è quindi probabilmente una notevolmente sottostima del reale costo climatico che però, anche così, nei primi 60 giorni di guerra equivaleva alla combustione di almeno 150.000 tonnellate di carbone.”
Studi successivi hanno preso in considerazione anche il calcolo delle emissioni derivanti dalla ricostruzione degli oltre 100.000 edifici danneggiati di Gaza e hanno evidenziato che verranno prodotti almeno 30 milioni di tonnellate di Gas Serra.
Oggi dei circa 25,4 milioni di profughi presenti nel mondo, la metà proviene da tre Paesi: Siria, Afghanistan e Sud Sudan. L’altra metà dei profughi proviene soprattutto dal Corno d’Africa. I flussi migratori sono legati a situazioni contingenti o a conflitti. Dati ufficiali di “uscite” dalla striscia di Gaza ancora non ci sono, ma si può pensare che almeno 100.000 civili abbiano lasciato la striscia. La possibilità per i Palestinesi che hanno lasciato Gaza è il ricongiungimento con famigliari che vivono in Europa, in Canada e U.S.A.. Sono questi i Paesi dove ci sono significative presenze di comunità Palestinesi. Certamente l’incremento della migrazione comporterà uno sbilanciamento economico dei Paesi di accoglienza, ma la sfida che questo ennesimo conflitto ci sta dando è quello di promuovere la voce dei palestinesi, sostenere i loro diritti calpestati dalle continue aggressioni e violenze. Valorizzare la loro presenza e il contributo che ognuno di loro potrà portare. In sintesi, facciamo nostro il diritto umanitario per contrastare chi la guerra la causa e determinare le condizioni perché i Palestinesi possano tornare in libertà nella loro terra.
Come vede il futuro di questa guerra?
L’odierna situazione politica non sembra dare prospettive per una risoluzione a breve del conflitto in corso. Dovremo fare i conti con ancora tanti altri morti, feriti e distruzione. Di certo la questione palestinese non si risolverà neppure dopo la fine del conflitto, troppi gli interessi politici ed economici dell’area coinvolta. Mi auguro si apra un percorso di pace e che il fulcro siano i diritti universali. Il futuro è comunque abbastanza oscuro: dopo una guerra, nel nostro caso aggressione, risollevare la popolazione dalle esperienze passate è difficile. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2012 dichiarava Gaza a rischio di invivibilità entro il 2020. Proviamo a pensare cosa è oggi. Non ci troviamo di fronte solo a una questione economica, di ricostruzione case e infrastrutture. Questa aggressione lascerà donne, uomini e soprattutto bambini con gravi conseguenze sulla salute mentale, una sofferenza collettiva a lungo termine.
Quali sono stati i momenti più significativi o toccanti che hai vissuto durante la tua esperienza nella striscia di Gaza?
Tanti i momenti che mi hanno “segnato” e cambiato. Nelle prime esperienze in Cisgiordania, ai check point ho visto giovani soldati israeliani, ragazze e ragazzi con obbligo leva dai 18 ai 21 anni con l’apparecchio ortodontico in bocca che mi puntavano un fucile obbligandomi in coda con decine di donne uomini e bambini, per i controlli. I primi bambini visitati nel centro di rianimazione allo Shifa Hospital avevano perso le gambe nel corso di un attacco dei carri armati israeliani mentre erano in un campo di fragole a fare la raccolta. Questi 3 ragazzini tra i 12 e 13 anni, sono entrati nel progetto di adozione a distanza di Gazzella. Li ho visti crescere, fare riabilitazione e si sono sposati. Nei pronto soccorso degli ospedali durante gli attacchi i feriti arrivano numerosi e i letti a disposizione sono subiti occupati. Tanti vengono sistemati sul pavimento e il sangue è ovunque. All’obitorio ho visto bambini con parti del corpo mancanti. A una ragazzina, in un pronto soccorso affollato, suturavano la ferita alla testa. Quando ha visto che la stavo riprendendo, si è messa la mano sulla bocca per non far sentire i geniti di dolore. Alle manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno a migliaia i palestinesi sfilavano pacificamente e chiedevano la fine dell’assedio. L’esercito israeliano in risposta sparava sui dimostranti. Abbiamo raccolto sulle ambulanze ragazzini con convulsioni, dovute ai gas lacrimogeni, feriti e morti. Il 7 ottobre scorso ero a Gaza e ho vissuto fino al 1 novembre sotto le bombe con i Palestinesi. Le tante esperienze vissute contribuiscono tutte a farmi restare ferma sul rifiuto di chi calpesta i diritti e non ha rispetto della vita.
Non posso però non tornare al giorno che sono uscita dalla striscia di Gaza, il 1 novembre scorso. Sentimenti ed emozioni: il desiderio di rassicurare con il mio rientro la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene, ma il dolore, grande, di lasciare le persone amiche, i bambini.

Cosa possiamo fare noi qui per esprimere il nostro sconcerto su questo conflitto?
Studiare, informarvi, approfondire. Confrontatevi soprattutto nelle diversità. Non lasciate che sia il “pensiero comune” quello debole, superficiale, banale, vuoto, approssimativo che mette in luce o evidenzia solo alcuni aspetti. Non cercate di “essere” o “stare” con il pensiero “più comodo” o del “presunto vincente”. Adesso la soluzione del conflitto a Gaza è un cessate il fuoco permanente, ma non è sufficiente. Per ragioni anagrafiche siete voi che scriverete la storia e costruirete nuove situazioni. Credo che più forte e più solido sarà il vostro pensiero, più efficace sarà la vostra azione. Fermare l’economia della guerra e dei conflitti vuol dire ripensare un nuovo modello di produzione, che non siano gli armamenti.

Cosa sperano i bambini di Gaza?
I bambini di Gaza chiedono la fine del conflitto, di tornare nelle loro case e a scuola, di tornare a giocare con gli amici. Nonostante la loro drammatica quotidianità, esprimono una grande capacità di immaginare un futuro di normalità, di affetti, di relazioni. Loro che da oltre 6 mesi stanno cercando di sopravvivere a bombe e proiettili, alla paura di perdere i propri cari mentre sono costretti a fuggire attraverso strade disseminate cadaveri. Penso ci stiano dando un grande insegnamento.
Intervista a cura della classe 5^I